«Tiberio Bentivoglio, questo imprenditore con la schiena dritta: “Sono solo, disperatamente solo. Solo nel quartiere in cui sono nato e cresciuto, dove nessuno mi saluta più, nessuno entra in questo negozio di articoli sanitari e corredini per bambini. Il negozio è deserto. E il bello è che qualche avvocato dei loro dice nei processi che l’ho fatto per guadagnarci, che ho inventato tutto per soldini. Eccoli qui i miei soldini. Diffamato e rinnegato nella mia terra. La mia casa è ipotecata perché non ho potuto pagare i contributi dei dipendenti, sennò avrei dovuto licenziarli. Non posso usarla nemmeno per chiedere un mutuo. Quando ho deciso di ribellarmi ero orgoglioso, mi sentivo un soldato. Ora mi sento un verme. Mia moglie e i miei figli ogni tanto piangono e mi sembra di sentirli: “perché l’hai fatto?” […]Io non ho perso la mia dignità con la ‘ndrangheta, l’ho persa con lo Stato. Qui lo Stato non esiste. Meglio: lo Stato che c’è qui è troppo piccolo. Troppo pochi quelli che lo rappresentano davvero. […] Qui nella mia terra io sono uno che perderà il negozio e la casa, costretto a vivere come un prigioniero. Uno a cui in anni e anni […] nessuno ha saputo trovare una legge, un provvedimento che dicesse a tutti: ‘lui per noi è un esempio da difendere’. Gliel’ho detto in Commissione antimafia: “Noi siamo i feriti che eravamo in trincea. Curateci e rimandateci lì, fateci diventare contagiosi. Altrimenti questo male non si sconfiggerà mai”1Nando dalla Chiesa, «Mafia: la solitudine di Tiberio, imprenditore che osò resistere al pizzo», Il Fatto Quotidiano, 13/07/14.»
di CONSOLATA MAESANO –
Quanto chiasso fanno i sogni della gente perbene quando le angherie dei delinquenti li mandano in frantumi? Qual è la dose massima di ingiustizia che l’anima di un onesto può tollerare prima dell’assuefazione? Quante colpe ha uno Stato che fa spallucce, che sparisce nel momento del bisogno, che toglie ossigeno a chi sta soffocando? Fanno più danno gli attentati dei mafiosi o l’isolamento dalla propria comunità?
Tiberio Bentivoglio, imprenditore e testimone di giustizia reggino, risponde a questi e tanti punti interrogativi uncinati che, da decenni, lacerano le sue attività commerciali, la sua famiglia, la sua serenità, il suo corpo; ma mai la sua dignità e la sua voglia di giustizia.

Tiberio Bentivoglio sceglie di difendersi con le parole, con l’inchiostro e le pagine del suo testo C’era una volta la ‘ndrangheta. L’opera sorprende per l’escamotage narrativo adottato: la storia è ambientata nel futuro, dove un bambino chiede l’aiuto del nonno per una ricerca sulla ‘ndrangheta del passato. Il lettore viene catapultato in un divenire utopico, dove la criminalità è stata definitivamente sconfitta grazie al buon senso dei cittadini e alla presenza delle istituzioni.
L’anziano inizia a raccontare al nipotino le storie di alcuni suoi amici imprenditori vittime negli anni passati della criminalità: gli alter ego di Tiberio Bentivoglio permettono a quest’ultimo una lunga catarsi, che ripercorre quasi un trentennio di soprusi: dalle prime richieste di pizzo fermamente rifiutate, ai conseguenti furti («si presero da soli i soldi del pizzo non pagato»), alle denunce, alle interminabili e sfiancanti saghe legali, sino ai numerosi attentati che mandano in fumo saracinesche, merci, locali e anni di sacrifici («il negozio fu dato alle fiamme. Fu distrutto tutto. I vigili del fuoco nell’immediato non riuscirono a entrare nel negozio perché la temperatura era altissima e dovettero indossare delle tute speciali e posizionare dei vortici per aspirare il denso fumo che avvolgeva l’intera superficie. I sacrifici di una vita si erano trasformati in un grande accumulo di polvere nera, non era rimasto niente da poter vendere»), giungendo sino a quello che quasi costa la vita al commerciante («ti posso solo dire che dalla paura mi son fatto addosso. Sentivo un bruciore pazzesco, come se un ferro arroventato mi avesse perforato la carne che già puzzava di bruciato, poi il dolore lacerante, mentre il sangue sgorgava come acqua di sorgente. Però la paura più grande ce l’ho avuta quando ero rannicchiato dietro le lamiere: non sentì più alcun rumore e pensai che si stessero avvicinando per uccidermi»).
Oltre alle fiamme e ai proiettili e al loro devastante impatto psicologico e familiare (descritto in maniera lucida e magistrale), Tiberio Bentivoglio si ritrova costretto a subire la solitudine e l’isolamento da parte dei membri della sua comunità («Il quartiere dove era nato era diventato ostile, persino i suoi compagni d’infanzia cercavano di evitarlo»), l’assenza delle istituzioni e di una adeguata rete di supporto per chi, come lui, sceglie di denunciare, volta a snellire le scartoffie e a rendere possibile una ripartenza («lo Stato assiste indifferente, celandosi dietro una burocrazia lenta, quello stesso Stato che invita e sollecita tutti i commercianti a denunciare il racket, promettendo assistenza, risarcimenti adeguati, sostegno materiale e morale, i cui silenzi oggi recepiamo come indifferenza e che certamente offendono il nostro coraggio»).
Una vicenda obiettivamente amara, la cui lettura tuttavia lascia un indelebile messaggio di speranza e di dignità. Pagina dopo pagina, al lettore appare chiaro il valore e il perché di ogni singolo e netto “no” che l’imprenditore ha detto alla ‘ndrangheta.
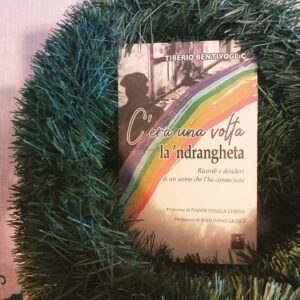
 Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”
Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”

