“Cristo si è fermato a Eboli” e assieme a lui lo Stato. Carlo Levi racconta un Sud povero ma immenso
«“Cristo si è fermato a Eboli”: Quali sono le ragioni dell’attualità di questo libro di Carlo Levi? Una letteraria e l’altra più politica, in un senso ampio. Letteraria perché è uno dei libri più importanti del nostro Novecento. Ma non è un romanzo: è un libro inclassificabile. La lingua di Levi è referenziale, riferisce di eventi, ma è anche fortemente evocativa, trasparente e poetica, questo libro è un unicum. Politica perché Carlo Levi non vuole redimere i contadini lucani: pensa che essi, anche involontariamente, anche non consapevolmente, esprimano una critica del nostro progresso, della nostra modernità, di come questa si è realizzata in Italia»1Filippo La Porta, https://www.raicultura.it/letteratura/articoli/2020/01/Cristo-si–fermato-a-Eboli-di-Carlo-Levi-667d0f61-fce7-48e7-815b-f9173356dee5.html
di CONSOLATA MAESANO – Cristo si è fermato a Eboli, una tra le vette più alte della letteratura memorialistica meridionale, vanta l’impronta di un piemontese, Carlo Levi.
Il medico torinese, militante antifascista tra le fila rosselliane di Giustizia e Libertà, trascorse circa due anni in confino nel piccolo centro lucano di Aliano (Gagliano, nel romanzo).
Circa dieci anni dopo, Carlo Levi raccontò l’esperienza nel capolavoro Cristo si è fermato a Eboli, emblematico sin dal titolo.
«“Noi non siamo cristiani – essi dicono – Cristo si è fermato a Eboli. Noi non siamo cristiani, non siamo uomini, non siamo considerati come uomini, ma bestie, bestie da soma, e ancora meno che le bestie, […] perché noi dobbiamo invece subire il mondo dei cristiani, che sono di là dall’orizzonte, e sopportarne il peso e il confronto”. Ma la frase ha un senso molto più profondo. […] Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l’anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia. […] Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore o un nemico o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina, oggi come tremila anni prima di Cristo: nessun messaggio umano o divino si è rivolto a questa povertà refrattaria. in questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma è un dolore terrestre, che sta per sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli»2Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, Einaudi, Torino, 1945
Un romanzo, un memoir, un saggio politico, un studio antropologico. E ancora: un diario, un reportage.
Cristo si è fermato a Eboli è un’opera talmente complessa da essere difficilmente inquadrabile in poche e rigide categorie. Carlo Levi, nel pilastro della letteratura del ‘900, si accosta con particolare sensibilità, rispetto e interesse a una cultura di cui intuisce ben presto la straordinarietà, dove il mito e l’arcaico si intrecciano a un’umanità istintiva e genuina.
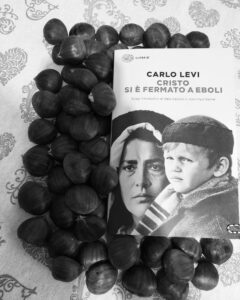
La povertà in cui vivono i contadini offre allo scrittore lo spunto per un’acuta esamina delle sue cause.
Toccante la descrizione di Matera e lo sconcerto della sorella di Levi dopo averla percorsa e aver visto coi propri occhi migliaia e migliaia di bambini costretti a vivere nelle grotte, con «le mosche che gli passeggiavano sugli occhi e quelli pareva che non le sentissero».
Una terra martoriata dalla malaria e, soprattutto, dall’indifferenza istituzionale in merito, che frena la classe politica locale e nazionale dall’adottare poche ma efficaci contromisure per debellare la malattia e le sue cause («Anche coi mezzi limitati di cui si poteva disporre in paese, si sarebbe potuto ottenere parecchio; ci si sarebbe potuti rivolgere alla Croce Rossa per avere il verde di Parigi per disinfettare quelle poche acque ferme nelle vicinanze dell’abitato; fare qualche lavoro per incanalare la fontana vecchia; far provvista di chinino, di atebrina e plasmochina. Erano tutte cose semplici e che, secondo la legge, sarebbero state obbligatorie. Cominciai a parlarne e a riparlarne al podestà, ma si guardava bene dal far nulla»).
Uno Stato percepito dai contadini come astratto, lontano, assenteista, nemico, artefice di ingiustizie e iniquità («Lo Stato, qualunque sia, sono «quelli di Roma», e quelli di Roma, si sa, non vogliono che noi si viva da cristiani. C’è la grandine, le frane, la siccità, la malaria, e c’è lo Stato. Sono dei mali inevitabili, ci sono sempre stati e ci saranno sempre»).
Tutte cause e conseguenze dell’irrisolvibilità dei problemi del Sud («Non può essere lo Stato a risolvere la questione meridionale, per la ragione che quello che noi chiamiamo problema meridionale non è altro che il problema dello Stato», bisogna «creare una forma di Stato di cui anche i contadini si sentano parte»).
Aliano, oltre che il luogo del confino, rappresentò per Carlo Levi anche la sua ultima tappa terrena: alla sua morte, nel 1975, l’intellettuale venne sepolto proprio nell’amata terra non toccata da Cristo e dallo Stato.






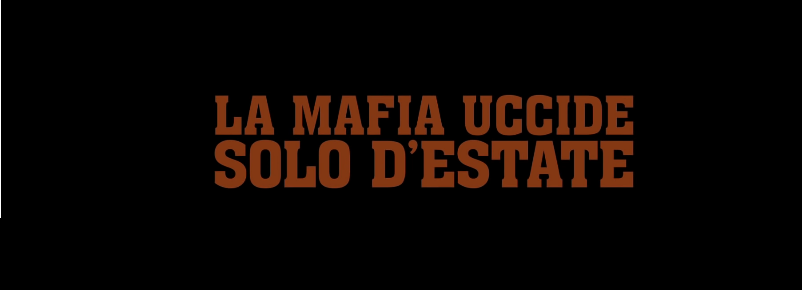



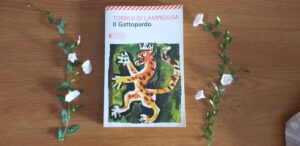


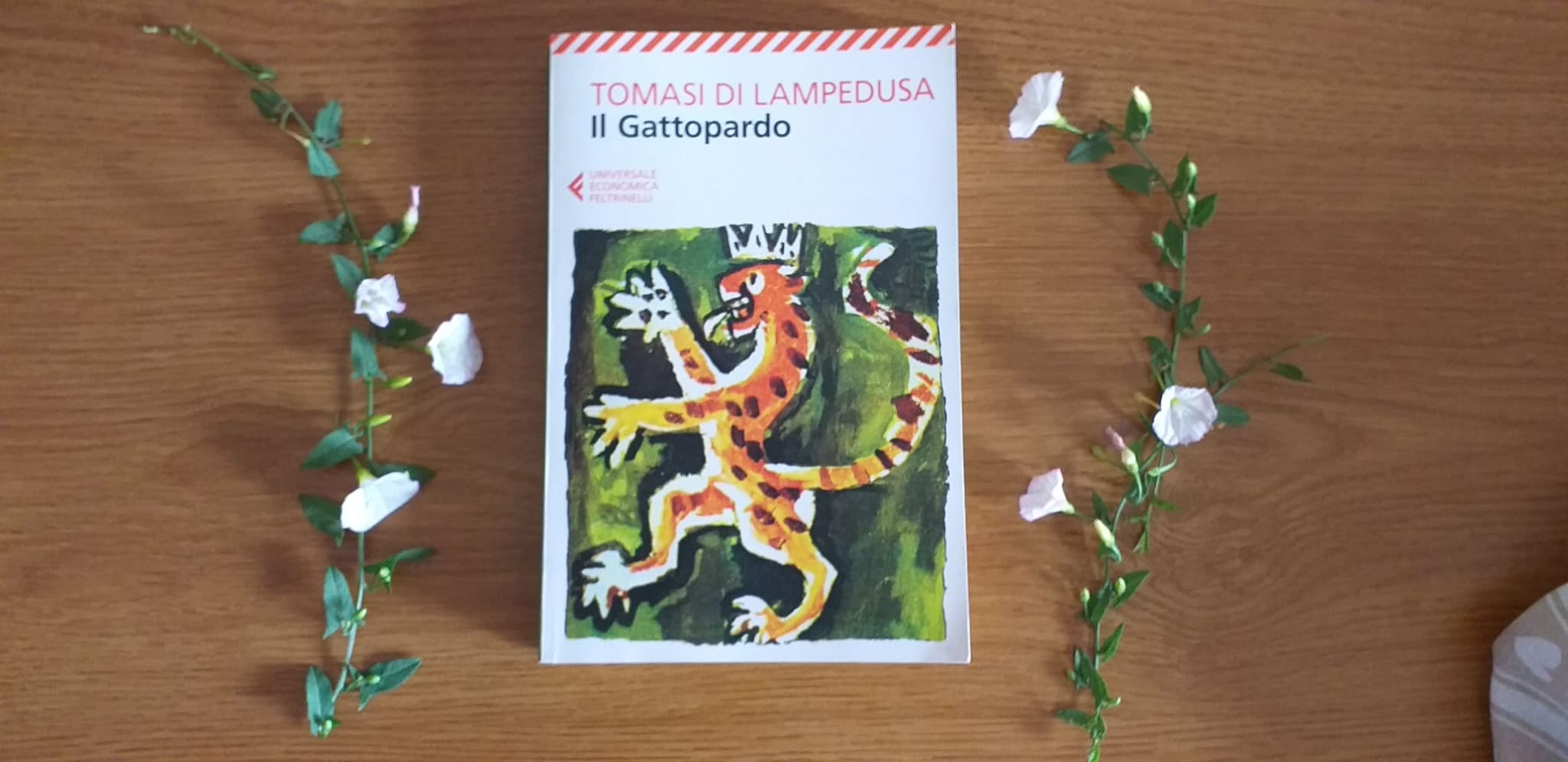



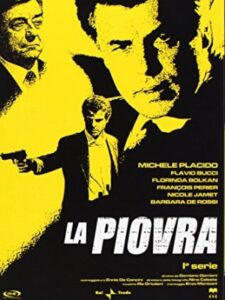


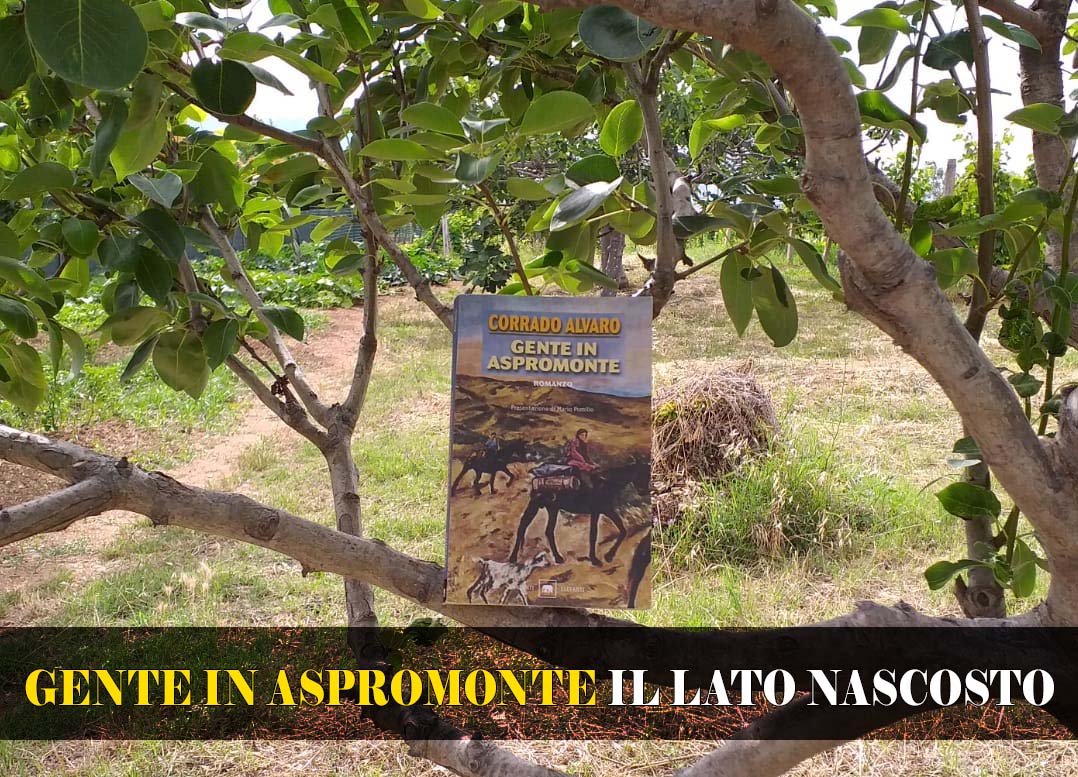
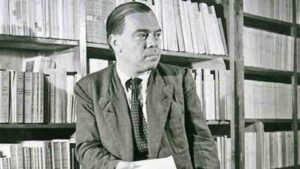
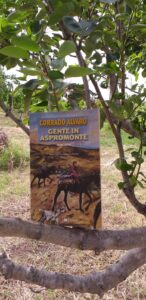



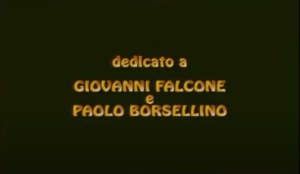

 Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”
Consolata Maesano, nata e residente in un piccolo paesino del profondo Sud Italia, pressapoco in riva allo Stretto di Messina. Una laurea magistrale in informazione e sistemi editoriali, una passione sconfinata per il giornalismo, un amore datato per la lettura e la scrittura, un talento raro per il binge watching delle serie tv, un legame forte con la sua terra. Le sue giornate oscillano tra un “non ho sogni, ho traguardi” e un “senza tregua, ma senza sosta”